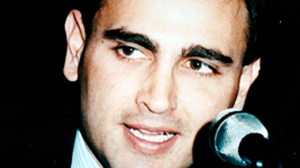Ogni
giorno diventa sempre più evidente come la grande sfida che abbiamo di fronte
sia quella della salvaguardia dei diritti umani e della dignità delle persone.
Se è
indispensabile, come dimostra la storia, che i diritti dell’uomo siano protetti
da norme giuridiche, è sempre la storia a dimostrare che queste non bastano e
che l’ordinamento giuridico non può consegnarsi all’idea di un diritto
immutabile e definito nell’unica volontà possibile della legge.
Esso
infatti rimanda anche al tramite dell’interpretazione giuridica ed al ruolo
della giurisdizione quale fattore di adattamento e condizione di vitalità delle
stesse norme scritte.
Nel
vecchio/nuovo orizzonte in cui siamo immersi a livello ormai planetario, la
giurisdizione continua a ricoprire un ruolo essenziale, poiché la «grande sfida
democratica non si consuma soltanto in uno scontro tra schieramenti politici ma
propone una costante tensione tra valori che trovano inevitabilmente nella
giurisdizione il luogo di visibilità e di possibile affermazione»; e proprio in
questo consiste «l’insopprimibile politicità della giurisdizione».
Così
sottolineava Carlo Verardi nell’intervento svolto a Venezia il 25 novembre 2000
al XIII Congresso di Magistratura democratica (cfr. L’orgoglio di stare in Magistratura democratica, in Questione giustizia, n. 5/2011, pp. 819 ss.),
uno dei suoi ultimi interventi in cui egli si espresse, come sempre, con parole
che potrebbero e dovrebbero essere fatte proprie da ogni magistrato, nella
consapevolezza che il principio di soggezione del giudice solo alla legge non
comporta soltanto il diritto a non subire le invadenze altrui, ma anche il
dovere di esercitare l’indipendenza a favore di tutti e nei confronti di tutti
senza distinzione: una funzione tanto più essenziale e irrinunciabile, quanto
più sulle soglie del mondo si affacciano, nelle forme più diverse, nuovi
diritti che reclamano riconoscimento e protezione e riemerge in tutta la sua
forza – per ricordare Carlo Verardi con altre parole indimenticabili, quelle di
Pino Borrè – la necessità di «esplorare», alla luce del Costituzione, «gli
spazi praticabili per la tutela (…) dei soggetti più deboli, dei
sottoprotetti, degli svantaggiati», dando nuovo impulso al ruolo della giurisdizione
come «attitudine costruttiva dell’uguaglianza».
Recuperare
l’orizzonte degli interessi materiali serve non soltanto ad orientare i
processi di formazione delle leggi, ma anche i giudici nel compito di
attuazione imparziale della legge: imparzialità non significa infatti
indifferenza ai valori sottostanti al disegno costituzionale, né vi è incompatibilità
tra terzietà e «scelta di campo», poiché «vi sono molti casi in cui la terzietà
– in quanto condivisione di una convenzione emarginate, non adeguamento in uno
schema già predisposto di rifiuto, è essa stessa scelta di campo» (G. Borrè, Le scelte di Magistratura democratica,
in Questione Giustizia, 1997, p. 282)
Come
veniva sottolineato già nel convegno della Fondazione Verardi tenutosi a
Bologna il 23 ottobre 2004 sul tema dei diritti fondamentali, in una fase della
storia in cui le violenze quotidiane, nelle forme più diverse, l’orrore della
guerra e il terrorismo, la cancellazione delle persone attuata, anche fuori
della guerra, in nome di politiche di sicurezza che escludono, confinano e
degradano esseri umani in cerca di asilo e speranza, e tante altre drammatiche
realtà sottolineano l’urgenza di una nuova «codificazione», di un
rimodellamento delle basi ideali e culturali su cui tracciare il nuovo ordine
giuridico mondiale, diventa ancora più chiaro che deve rafforzarsi un impegno
rivolto non a creare barriere e distanze, quanto invece al loro definitivo
superamento.
Ciò
sollecita i compiti e le responsabilità di ogni istituzione, ma sottolinea insieme,
in modo sempre più pressante, la necessità di strumenti, di luoghi, di
occasioni in cui gli uomini tornino a trovare la capacità di comunicare e di
ascoltare come condizione essenziale della convivenza, fattore di sviluppo
della pace sociale e presupposto di realizzazione della dignità delle persone.
Anche tra
i magistrati ed all’interno delle loro associazioni deve maturare la
consapevolezza che la democrazia non è fatta di continui scontri, di accuse e
intolleranza. Essa è fatta di confronto pacato e sereno, di dialogo
costruttivo, di volontà di concorrere insieme alla faticosa costruzione del
diritto obiettivo.
L’appartenenza
ideale a questo o quel gruppo non si trasforma in faziosità ed acquista tanto
più significato, se e quanto più riesca a porsi quale aspetto di una dialettica
che non predilige l’invettiva al merito dei problemi e non ignora le differenze
di opinioni, ma nel leale e reciproco riconoscimento delle diversità di cui
ciascuno è legittimo portatore, le assuma come stimolo per la crescita
democratica e la ricerca del bene comune.
È questa
l’idea di associazionismo giudiziario cui si è sempre ispirato e che ha
concretamente praticato Carlo Maria Verardi, la cui adesione ideale e culturale
ad Md mai si è trasformata in posizione preconcetta di parte, e che anche
nell’intervento più sopra richiamato dichiarava il suo orgoglio di farvi
parte soprattutto allorché «il gruppo
riesce ad uscire fuori dallo steccato della giurisdizione, a parlare ai
cittadini con le armi della cultura giuridica, dell’impegno personale e vorrei
dire anche con uno stile di pacatezza e semplicità che bisogna sforzarsi di
mantenere», come quando «ha ricordato le ragioni del diritto contro la guerra,
quando ha contribuito a fondare una rivista che è diventata punto di
riferimento fondamentale per tutti i giuristi che si occupano del tema centrale
dell’immigrazione, quando è stata capace di ritornare a ragionare sulle
tossicodipendenze e sulla riduzione del danno superando le semplificazioni
correnti o a confrontarsi, senza apriorismi, sui temi bioeteci». Le conquiste –
egli aggiungeva – «sono venute solo quando la magistratura ha trovato unità non
sulla base di chiusure corporative ma di un rilancio culturale e professionale».
Siamo
grati a Carlo Verardi anche per questi insegnamenti e per la limpidezza e
coerenza con cui per primo ha saputo attuarli.
Per
ricordarlo in modo ancora più forte, per favorire un incontro quotidiano con la
sua figura, anche da parte di chi non l’ha conosciuto, a lui verrà intestata,
con una cerimonia che si svolgerà a Bologna il 20 ottobre alle h. 12.30, la
corte interna del Palazzo di giustizia di via Farini.
Nel
pomeriggio seguirà, in Salaborsa, un convegno dedicato al diritto del lavoro
con la partecipazione della Fondazione, che è tra i patrocinatori
dell’iniziativa.
Saranno
nuove occasioni illuminate dalla ricchezza del pensiero che ci ha lasciato e
riscaldate dall’affetto con cui lo circonderemo.
Gianfranco
Gilardi, 15 settembre 2017