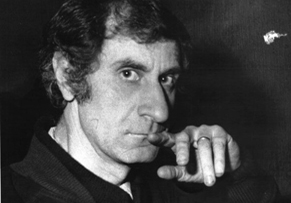Nel luglio
scorso ci ha lasciato Gabriele Cerminara,
uno dei fondatori, il 4 luglio del 1964, di Magistratura democratica, di
cui fu esponente di rilievo nel c.d. gruppo romano. Fu questa
l’articolazione di Md che, non senza forti conflitti anche interni, si
caratterizzò per la sua netta collocazione a sinistra dalla fine degli anni
Sessanta e per tutto il decennio successivo, in un’epoca spesso drammatica, ma
feconda e vitale nella storia della “corrente” e della magistratura, tra
scissioni e aspri conflitti con l’esecutivo, lotta contro le incrostazioni
autoritarie nell’ordine giudiziario, per la libertà di critica alle sentenze e
per l’attuazione della Costituzione.
Md di oggi è, ovviamente, assai
diversa da quella di quasi cinquant’anni fa: molta acqua è passata sotto i
ponti, dalla scissione del dicembre 1969 del gruppo “beriano” (che poi dette
origine ad Unità per la Costituzione radicalizzando a sinistra MD), alla
stagione del terrorismo e della legislazione dell’emergenza, alla progressiva
crescita dell’indipendenza della magistratura fino alla fase, ancora incerta e
di difficile definizione, della nascita di Area. Ma della prima fase, fino agli
anni ‘80, Gabriele fu un protagonista in Md, schierato in difesa del garantismo
e dell’uguaglianza, dell’autonomia di MD rispetto alle mire egemoniche e al
moderatismo PCI, che affermava il primato della rappresentanza politica dei
lavoratori e delle compatibilità del sistema rispetto all’autonomia delle
organizzazioni sindacali e delle istituzioni. Un protagonista che si è sempre
schierato per il garantismo e l’uguaglianza, ma senza alcun personalismo,
perché credeva nell’azione collettiva del gruppo e nell’ intervento nelle
dinamiche espresse dalle articolazioni della sinistra e dalle lotte sociali. Lo
interessava il rapporto tra masse e potere. Affermava che il potere è legittimo
se deriva dalle masse, dalle loro articolazioni in cui si esprime il popolo
sovrano, non dalle élite. Soggetti collettivi, non singoli individui. Soggetti
collettivi, non leader. L’”intellettuale collettivo” Magistratura democratica
per lui era cosa seria, importante, nel quale impegnarsi. Propugnava
l’autonomia di Md rispetto a tutte le forze politiche, anche rispetto a quelle
di sinistra. Grande conquista, risultato di un impegno militante inizialmente
non condiviso da tutta la corrente. Altri gruppi auspicavano l’assimilazione
politico-culturale alle elaborazioni e alle prese di posizione del PCI.
Magistrato di sinistra, non
organico ai partiti della sinistra, criticava i “professorini”, i magistrati
che esaurivano il loro ruolo nel gareggiare fra loro in bravura
tecnico-giuridica. Il magistrato democratico deve essere tecnicamente
preparato, ma deve avere anche, o soprattutto, cultura politica. Cultura
giuridica e cultura politica. Volontà di cambiare la realtà secondo i principi
della Costituzione, anche nelle istituzioni. Nello stesso tempo, però, deve
conoscere anche i limiti del proprio ruolo. Capace delle polemiche più aspre,
assertore dell’assoluta libertà di critica alle sentenze, come dimostrano i
suoi contributi a Quale giustizia, Gabriele era però alieno da ogni
protagonismo e praticava con convinzione un
self restraint, che imponeva il rifiuto di ogni personalizzazione. Ha
sempre conciliato la nettezza e talvolta l’asprezza del dibattito dentro MD con
un profondo rispetto umano per i suoi contraddittori, con un senso di
affettuosa amicizia e umana solidarietà.
Il tema dei rapporti tra
giustizia e politica è più che mai attuale. Lo era ieri (caso Sifar-De Lorenzo,
caso Rocco), lo è ancor oggi (corruzione, rapporti tra uomini politici e
mafia), lo sarà domani. Giusto ricordare un altro esponente di rilievo
del gruppo romano: Ottorino Pesce. Segreto militare: indagare o fermarsi?
Avocazione da parte del procuratore generale. Il processo per la strage di
Piazza Fontana è contrassegnato dalle imposizioni del segreto di stato che ne
hanno segnato la morte. Eppure la questione è ancora attuale, ed è stata
all’esame della Cassazione nella sentenza del 19 settembre scorso nel processo
per il sequestro di Abu Omar.
Md come “intellettuale
collettivo” oggi appare deperito. Il gruppo discute troppo poco al suo interno
e poco all’esterno, mentre il dibattito resta affidato in larga parte agli
sfoghi di militanti e simpatizzanti sulla mailing
list. Neppure di riforme alla Costituzione ci si occupa sempre con
l’impegno dovuto: non si è avviato alcun dibattito sull’introduzione in
Costituzione del “Fiscal Compact” (riforma dell’art. 81).
Profondamente legato al
principio di eguaglianza, all’art. 3/2 della Costituzione, Cerminara ricordava
a tutti, costantemente, la condizione della classe operaia e l’impegno della
Repubblica e, quindi, di tutti i magistrati perché tra i cittadini fosse
realizzata una maggiore eguaglianza. Riteneva il carcere un male talvolta
necessario, ma da limitare al massimo, e rifiutava la logica del carcere come
unica soluzione al disagio sociale. Quando è stato collocato in pensione,
coerente con le sue convinzioni sulla pena nell’accezione dell’art. 27 della
Costituzione, si è impegnato come assistente volontario a Rebibbia, ha
organizzato spettacoli teatrali con i detenuti come attori. Il suo teatro è
sempre stato ideologicamente schierato dalla parte degli umili, dei diseredati.
Amava gli uomini. Era un
umanista concreto, un artista, uno scultore. Discorsi semplici, chiari,
elementari, in una tensione morale di continua ricerca di coerenza tra idee e
stile di vita.
Vincenzo Accattatis, Sergio Mattone, Gianfranco Viglietta
(26 settembre 2012)