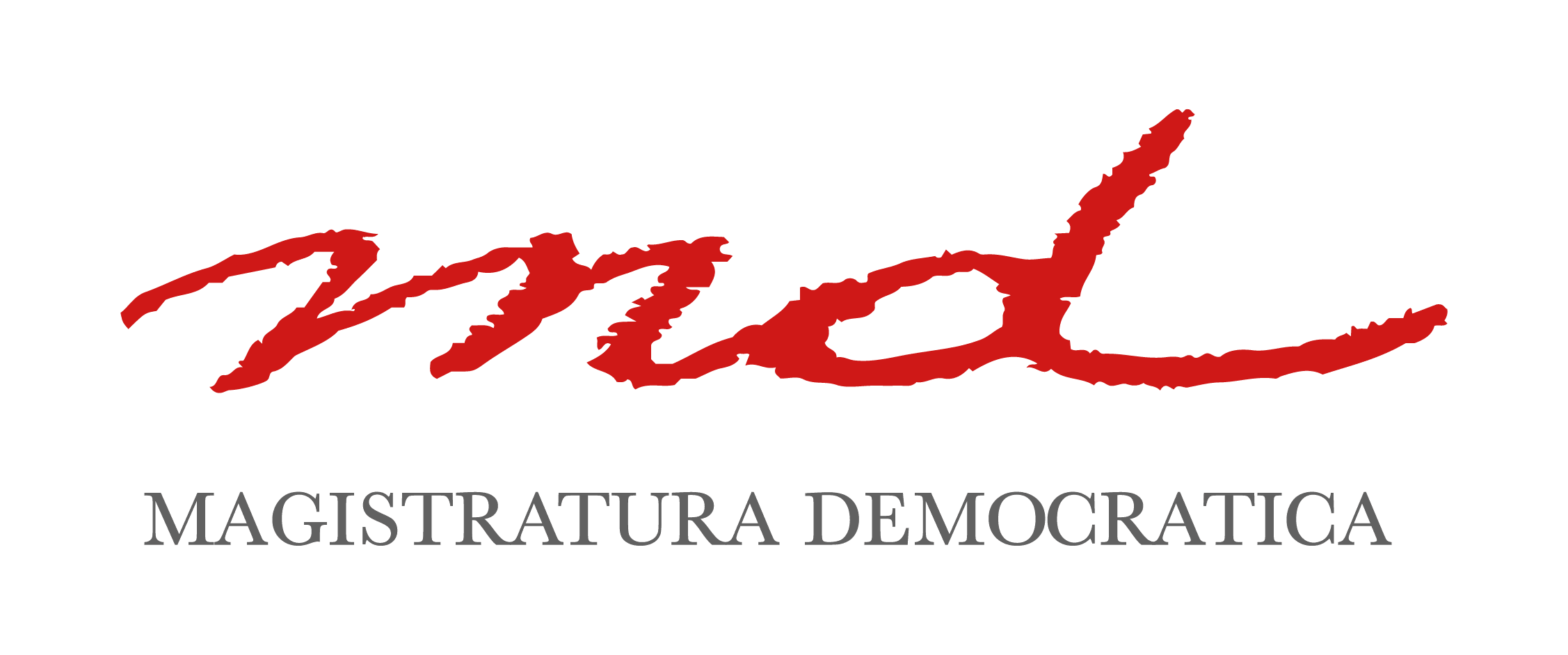1.
Il Lavoro sugli STANDARD
Ieri,
19 luglio, il Csm ha presentato le relazioni finali sugli standard
con un incontro pubblico cui hanno partecipato il Primo Presidente e
rappresentanti del Consiglio direttivo della Cassazione,
rappresentanti delle Corti di appello/Consigli giudiziari,
rappresentanti del Ministero giustizia.
Dopo
l’introduzione del Vice presidente Vietti e della Presidente della
IV Commissione, De Rosa, e dopo la presentazione dei 4 settori di
lavoro del Gruppo tecnico sono intervenuti numerosi componenti del
Csm e colleghi rappresentanti dei distretti.
L’apprezzamento
per il lavoro è stato unanime, con una lettura politica dei
risultati davvero incoraggiante contenuta nelle parole del Vice
presidente e del cons.Calvi. Tutti gli interventi hanno sottolineato
la necessità che quanto si è fatto venga sviluppato nelle parti
mancanti del primo grado ed esteso ai gradi successivi, così da
permettere l’avvio a regime della procedura di valutazione
proposta.
In
questa prospettiva il Gruppo di lavoro ha presentato nelle relazioni
finali i passi concreti che il Csm dovrebbe intraprendere per dare
gambe e corpo al lavoro svolto.
Anche
il Cons.Pepe ha espresso apprezzamento per la qualità del lavoro,
proponendo poi dei correttivi alle scelte tecniche che il Csm
dovrebbe adottare nel dare attuazione al progetto.
Sono
sicuro che quanto è stato detto ieri sarà seguito da passi coerenti
del Csm (istituzione della struttura tecnica; completamento della
raccolta dei dati; estensione ai settori non esaminati, e così via)
e che il sistema potrà essere migliorato nel tempo.
In
questo senso devono essere apprezzati i rilievi critici che ancora
ieri alcuni colleghi hanno espresso per la carenza di dati ritenuti
importanti o per la assenza di un chiaro bilanciamento dei parametri
per i magistrati che negli uffici piccoli e medio-piccoli trattano
materie diverse o, addirittura, operano a cavallo fra civile e
penale.
Ciò
che comunque possiamo dire è che il Csm sta approvando
definitivamente la metodologia che vede lo standard nazionale
rappresentato da un intervallo statistico che si colloca attorno alla
mediana della quantità di produzione rilevata nel quadriennio per
gruppi omogenei di magistrati (cluster).
2.
I CARICHI ESIGIBILI
Questa
formula tecnicamente infelice è ora legge. Ho già scritto del modo
maldestro con cui questo parametro è stato utilizzato in passato e
ora introdotto nell’art.37 della manovra economica. Ho già scritto
di come sia, purtroppo, significativo che i carichi esigibili siano
presenti nello stesso articolo che prevede incentivi per
l’abbattimento dell’arretrato. Claudio, che è intervenuto su
questi temi più volte, para ora di “fordismo”. Io vorrei
evidenziare:
–
per il civile e il penale (gestiti da numeri alti di magistrati
gravati da affari disomogenei per oggetto, numero di parti, etc. che
non sono standardizzabili) non è di fatto possibile allo stato
individuare il punto di “breack even”, inteso come il punto oltre
il quale l’aumento della domanda e del carico comportano per il
magistrato una situazione di sovraccarico e una riduzione della
stessa capacità di smaltimento;
–
i dati statistici esaminati ai fini degli standard evidenziano
situazioni organizzative e carichi di lavoro molto diversi, elemento
che assieme ad altre considerazioni ha reso necessario non adottare
come standard nazionale il semplice dato mediano, ma un intervallo
statistico più ampio; analoga soluzione non credo potrebbe essere
adottata a livello di ufficio, così che, se colleghiamo il carico
esigibile al progetto di smaltimento dell’arretrato, ci potremmo
trovare a dover definire il rapporto carico-smaltimento ufficio per
ufficio, con una babele di ragionamenti e di soluzioni che
confliggono irrimediabilmente con il tentativo di razionalizzare il
sistema su scala nazionale;
–
l’applicazione del rapporto carico esigibile-progetto di
smaltimento alla situazione attuale comporterà privilegi per gli
uffici meno organizzati e con performances peggiori, in possesso di
margini di quei miglioramento che non hanno più gli uffici e i
singoli magistrati che già hanno fatto uno sforzo massiccio.
3.
Sulla base di quanto detto, poche considerazioni:
a)
in assenza della identificabilità scientifica del punto di breack
even, la magistratura rischia di finire impiccata ad un “numeretto”,
proprio ciò che tutto il lavoro sugli standard ha saluto evitare.
Posto che un ufficio o un magistrato che ricevono 500 producono
(ammettiamo) 450, che quelli che ricevono 800 producono (ammettiamo)
600 e quelli che ricevono 1.000 salgono (ammettiamo) a 750, chi potrà
negare che 700 non sia un valore “esigibile” ragionevole ? e che
lo sarà anche per chi riceve 500, che si troverebbe così costretto
ad esaurire tutto visto che altri producono molto di più ? E
chi ci dice che dopo lo sforzo per produrre un 5% o un 10% in più
per qualche anno (dietro compensi incentivanti), una parte di quel
10% in più diventi parte della quota esigibile in futuro ? in altre
parole: fissato il numeretto magico (che l’art.37 esclude che possa
essere più basso di quanto avviene oggi) , chi esclude futuri giochi
al rialzo e rincorse emulative ?
Chi
di numeretto ferisce di numeretto può perire. Spero di sbagliarmi.
b)
Ho sostenuto ieri una cosa semplicissima che le obiezioni al lavoro
sugli standard mi hanno reso evidente: la paura delle
valutazioni diffusa tra i magistrati genera reazioni neutralizzanti.
La provocazione del cons.Pepe (portare l’intervallo statistico a
20-80) si muove in questa direzione: aumentare l’intervallo per
includere nello standard quanti più colleghi è possibile. Ora,
premesso che un valore medio che include tutti da 20 a 80 è una
finzione di media che ci verrebbe rinfacciata da chiunque
guardi il nostro lavoro con senso critico, questo appiattimento, che
riconduce allo standard, e quindi alla normalità, chi a parità di
condizioni di lavoro produce (i numeri sono a mero titolo di esempio)
80 e chi produce 150, renderebbe nei fatti simili per effetti di
fronte al valutatore due valori che sono oggettivamente tra loro
incommensurabili e avrebbe una prima conseguenza: giustificare
le patologie. Da un lato, spingerebbe alcuni a distinguersi dal
gregge grazie al superamento del valore più alto pari
all’ottantesimo percentile (e dunque muovendosi in modo non
facilmente censurabile sulla scia della norma sugli incentivi), con
meccanismi che mettono in crisi ciò che si sostiene, e cioè troppa
produzione è un male ed equivale al crollo della qualità.
Dall’altro, consentirebbe a chi si colloca sul 21° o 22°
percentile di posizionarsi nell’area di tranquillità e non
sindacabilità, sol che abbia l’accortezza di garantire buona
qualità delle singole decisioni (risultato certo più facile quando
si produce la metà dei colleghi di ufficio o di cluster);
c)
Se la soglia di smaltimento accettata si colloca già al 20°
percentile (il che significa che 80 colleghi simili su 100 producono
di più, e spesso molto di più) si perpetua un meccanismo che
già oggi ha effetti devastanti: la disparità di trattamento
all’interno degli uffici. Perché non vi è dubbio che di fronte
all’esigenza di produrre di più per avere gli incentivi, i capi
ufficio finiranno per spremere di più coloro che già oggi danno di
più. Mentre sarebbe fisiologico il contrario: premiare chi lavora
bene ANCHE mediante la capacità di riequilibrare carichi e risultati
ottenendo di più da coloro che oggi danno meno. Ma se si abbassa
tanto la soglia dello standard, chi produce meno ha dalla sua un dato
“normativo” che lo definisce nella media e, dunque, non
censurabile sul piano valutativo;
d)
Ribadisco che non posso condividere la posizione di chi considera il
sistema di valutazione come un processo da cui difendersi. Chi si
colloca sotto il dato mediano potrà trovarsi in difficoltà nel
corso della procedura solo se anche il suo rendimento dentro
l’ufficio presenta dati anomali e se l’autorelazione e il
rapporto non rendono conto della qualità complessiva del lavoro.
Parallelamente, chi sta sopra la media potrà manifestare scarsa
qualità dei singoli affari e non corrispondenza alle esigenza di
qualità complessiva del lavoro. Autorelazione e rapporto sono
le due facce di una procedura trasparente e partecipata che
garantisce il magistrato e l’intero sistema da errori di
prospettiva e di valutazione derivanti dall’eccesso di significato
attribuito al solo dato numerico, rilevanza che l’intera procedura
ha superato attraverso i correttivi messi in campo.
Mi
rendo conto che il discorso è complesso e che a quanto dico si
possono fare obiezioni, tecniche e politiche. Ma ciò che oggi mi
preme evidenziare sono due pensieri di fondo:
–
i carichi esigibili sono diventati un boomerang che ai magistrati
causerà molti problemi;
–
è ora di porre a fine alle politiche di tolleranza corporativa di
quelle situazioni di scarso smaltimento (che per fortuna mi
paiono sempre minori in percentuale) che in modo ingiustificato
gettano discredito sugli uffici e che dentro gli uffici provocano
malumori e senso di ingiustizia e, a causa di questo, difficoltà
nella gestione collegiale e nella buona amministrazione dei carichi e
delle risorse.
4.
Gestire bene il lavoro sugli standard e verificare se da
esso possano trarsi informazioni statistiche utili anche per
definire, come da legge, i carichi esigibili è un compito difficile
che il Csm deve saper affrontare per dare coerenza al sistema, per
garantire ai magistrati dei riferimenti equilibrati, per dare
risposta ai bisogni della collettività.
Pur
nella profonda differenza fra la filosofia degli standard (per la
valutazione) e dei carichi di lavoro (per la gestione), un lavoro
intelligente può essere fatto da un autogoverno consapevole e capace
di porre rimedio anche a certi disastri. In questo, un coordinamento
fra il lavoro della STO sui flussi degli uffici e quello della IV
Commissione sugli standard mi pare una via obbligata che già ieri ho
sostenuto con forza.
Luigi
Marini (presidente di Magistratura Democratica)